Vacanze italiane
Foto in evidenza: la spiaggia del campeggio Marinella di Palinuro vista dall’alto. Più a destra, dopo l’altura della Molpa s’intravvede la spiaggia del Mingardo
Racconto (con aggiornamenti e modifiche) tratto dal volume
L’ERA GLACIALE. Storie di Serravalle e di un ragazzo del ’56, di Riccardo Lera (Edizioni Le Nuvole, 2019)
La partenza era stata strategicamente stabilita per le diciannove. Mio padre, smontato da un sei a due, chiese quattro ore di riposo, la prima delle quali la perse in superflue raccomandazioni a mia madre circa l’organizzazione logistica dell’intera spedizione; infatti, anche se mamma non sapeva calcolare quanto carico avrebbero dovuto sopportare per centimetro quadrato le quattro gomme dell’auto, per tutto il milione e sessantunmila metri che ci separavano dalla meta, tutto era già stato ampiamente controllato più volte.

Il vecchio Maggiolino AL 98401 era stipato dentro e fuori. Casa nostra era infatti pressoché deserta. Il piccolo vano bagagli sistemato nel cofano anteriore raccoglieva la paleria e i teli che costituivano la nostra robustissima Gifacò, tenda da campo base himalaiano, cinque metri per cinque e mezzo, veranda esclusa, a tre vani, due dei quali camere da letto, da tre posti l’una. La sua robustezza, scientificamente testata dai calcoli matematico-ingegneristici del pater familias era un dogma inscalfibile e come tale accettato senza alcun contraddittorio. La Gifacò stava oltre l’imponderabile. Come tutto il resto, d’altronde.
Sia il tettuccio che il cofano posteriore erano sommersi da masserizie varie, adagiate su due distinti portapacchi ad essi adeguatamente fissati da robusti elastici e fasciate da un telo impermeabile. Il culmine del bagaglio esterno superava abbondantemente i due metri e mezzo d’altezza.
Ma era l’interno dell’autovettura a trasportare la maggior parte delle nostre ricchezze; stipato fino all’inverosimile, lo scomparto posto dietro il sedile posteriore si presentava, per più di metà della sua lunghezza, pieno di ogni utensile da cucina, sedie e tavoli da campeggio, cibarie varie e frigorifero da campo.
Nell’esiguo spazio rimasto si dovevano accomodare mia madre e mia sorella maggiore di sette anni, Simona, le gambe magre incastrate fra carabattole varie e gli occhiali da ipermetrope inchiodati sul viso dal sedile anteriore di mio padre. Cosa abbia potuto vedere del viaggio resta a tutt’oggi circondato da un alone di mistero. Lei non ricorda. Ma poiché non porta più gli occhiali, il motivo va senz’altro individuato in un progressivo, traumatico-terapeutico accorciamento dei bulbi oculari per la prolungata compressione realizzatasi in quelle ore. È, in letteratura medica, l’unico caso di vacanza con finalità oftalmologiche.
Per mia sorella minore Alessandra, di anni quattro, si era ricavato uno spazio vitale di circa venticinque centimetri dove, sdraiata fra due cuscini, si incastrava perfettamente tra un baule e il tettuccio dell’abitacolo. Alessandra è stata, senza volerlo, la prima italiana munita di doppio air bag.

e di Sandra Pasquè Pasta, giornalista, amica di famiglia
Nostra madre, zero in matematica ma buon senso tanto, dopo aver preparato tutto in silenzio ci fece recitare un Pater Noster lungo viale Martiri, poco prima del casello autostradale.
Per un’ora si sorbì un interrogatorio stile Gestapo torrenzialmente sgorgato dalle corde vocali di chi mi fece con la y anziché con la x.
«Sì, Cesare.»
«Hai preso…?»
«Sì, Cesare.»
«Hai messo…?»
«Sì, Cesare.»
«Hai controllato…?»
«Sì, Cesare.»
Non lo stava nemmeno più a sentire.
Mi sembrava di udire lo stesso tono di quando le vecchiette ai rosari litaniavano, storpiandolo, Ora pro Eo, in un contrattissimo orapruè.
La mia posizione di undicenne, posta al lato del guidatore, detta “del morto”, poteva apparire la più comoda se non per il fatto che, oltre a chincaglierie varie, dovevo tener ben stretto fra le gambe, autentico kamikaze, la bombola del gas da venti chilogrammi necessaria a sfamare durante le vacanze l’intera truppa. Inoltre, nonostante la giovane età avevo compiti di navigatore, con attenta lettura delle carte e l’avvertenza di tener ben sveglio il conducente che si sorbì, soffocando nello stomaco ogni possibile sacramento, quasi venti ore di guida consecutive. Infatti alle diciannove in punto mio padre, pantaloncini corti e italica canottiera fresca di bucato, ricontrollati per l’ennesima volta il livello dell’olio, la pressione delle gomme, il liquido dei freni e non so che diavolo ancora, si pose alla guida direzione Palinuro, provincia di Salerno, e da lì, eccezion fatta per inderogabili necessità fisiologiche, mai più distaccò le mani dal volante, diventando tutt’uno con esso.
Inesistente la Torino-Piacenza, per imboccare l’Autostrada del Sole si risalì fino a Milano. Alessandra e Simona si addormentarono ben presto e i miei si scambiarono brevi fraseggi sui costi dell’intera operazione. Ma io avevo ben altro da fare che ascoltare quel bollettino economico familiare. Era il 1967, papà aveva preso patente e auto, di seconda mano, da due anni. Stavo per compiere il più lungo viaggio della mia infanzia; guardavo il lento succedersi delle uscite autostradali. Alle ultime ombre della sera sfilammo il casello di Sasso Marconi e mamma ebbe un sussulto:
«Fra poco c’è Gardelletta!»
Gardelletta, un nome che si era ripetuto sempre nelle memorie e nei racconti familiari, era il suo paese natale. I genitori di mia madre erano vissuti lì fino al 1935, una frazione di Marzabotto chiusa fra le montagne, nella valle del Setta. Nonno Giuseppe trasferì in Piemonte la sua famiglia, come operaio addetto alla costruzione di una grande opera viaria dell’epoca mussoliniana, la Serravalle-Genova. Fu così che scamparono al grande disastro, allo sterminio voluto dalle SS di Walter Reder.
Ma la piazzola per la fermata era nell’altra carreggiata e ormai era buio e tutto mi corse via in un attimo, tra profili di montagne inghiottiti dalla notte.
Alle tre del mattino tutti dormivano, forse anche mio padre, e il Maggiolino sembrava volar via tranquillamente da solo. Ma mi sbagliavo. Vedendo chiare le nuvole contro il cielo mormorai: «È l’alba.»
Ma il Tazio Nuvolari domestico, ben abituato ai turni in acciaieria, era ben desto, compreso nel sacro compito di traghettatore della moglie ronfante e della propria stirpe: «Non è l’alba, son le luci di Roma.»

E così la capitale mi sfilò accanto, ai lati del nastro d’asfalto, muta, silenziosa, immensa.
Venne giorno. Sebbene ancora inscatolati lungo la A1 dentro il nostro Maggiolino, il Sud si appalesava in tutta la sua sfavillante bellezza. Siepi di oleandri coniugavano infinite tonalità di rosa fra le due corsie autostradali e pini marittimi si aprivano verdissimi verso un cielo che già sapeva di mare e di sole.
Già. Il sole.
Quello con il passare delle ore saliva sempre più verso l’alto, nuotando profondo nell’azzurra volta italiana. Era giallo, luminosissimo ma, porca vacca, caldo, molto caldo e poi, verso mezzogiorno, schifosamente caldo e rovente.
Sudando ormai fradicio sotto le ascelle, le natiche pressoché incollate alla finta pelle del sedile, di tanto in tanto occhieggiavo preoccupato la bombola del gas serrata fra le mie ginocchia. Tastavo frequentemente la chiusura di sicurezza per tranquillizzarmi, ma il cercare un po’ di refrigerio aprendo anche di un solo dito il finestrino era assolutamente proibito. Mamma, a titolo di monito, già si era annodata un foulard in testa e ogni mio tentativo di accesso alla manovella dell’alzacristalli era bloccato da uno stentoreo quanto lamentoso muggito:
«Che aria!»
Alla fine trovai un compromesso adolescenziale, forse il primo e unico raggiunto in vita mia, con l’apertura parziale del deflettore anteriore, fortunatamente realizzato da Ferdinand Porche per la sua indistruttibile creatura d’acciaio. Per la verità quella fessura apportatrice di ossigeno fresco non era sufficiente e, mentre alle due di pomeriggio stavo ormai veleggiando verso una progressiva asfissia, le mie sorelle cuocevano sul sedile posteriore a fuoco lento, laocoonticamente abbracciate al frigorifero da campo in un estremo tentativo di sopravvivenza. Ho il vago sospetto che le frequenti incongruenze mentali presenti nella loro vita di donne adulte siano da ricercarsi in quella sorta di bagnomaria cerebrale al quale furono purtroppo esposte.
Finalmente, a tarda sera, attraversato il Lambro, un piccolo rio limpido e fresco, testimone di una cultura longobarda giunta fino a quelle basse latiditudini, giungemmo a destinazione. La Signora Chan, così era stata battezzata nel gergo familiare la nostra robustissima Volkswagen, era riuscita a non far scoppiare bielle e pistoni, portandoci sani e salvi fino al tanto desiderato camping Marinella di Palinuro raccomandatoci da Sandra Pasqué, una collega giornalista di mamma.
Gli ultimi chilometri di quell’anabasi familiare erano tuttavia risultati devastanti.
L’Autostrada del Sole ci aveva proditoriamente abbandonato all’altezza di Battipaglia e per proseguire la signora Chan si era dovuta sgommare la sedicente «strada» che, attraverso il vallo della Lucania, da Agropoli conduceva ad Ascea, Pisciotta e Rutino. Ore di calvario automobilistico che, snodandosi lungo itinerari da brivido, ci avevano sovente costretti a miracolosi sorpassi di mandrie di asinelli, a un’approfondita conoscenza geologica di tutte le pietre che costellavano mulattiere generosamente autopromossesi al grado di statali e a pazze corse di urlanti sciuscià scalzi al nostro passaggio.
Ma insomma. Eravamo giunti felicemente a destinazione.

Ora il Maggiolino, boccheggiando, in un ultimo sforzo aveva vomitato dal cofano l’indistruttibile tenda Gifacò ed espulsa tutta la famiglia Lera dalle due portiere laterali che, finalmente aperte, le garantivano un po’ di refrigerio all’ombra di un olivo secolare.
La paleria della tenda era pertanto lì, sulla nuda terra, dentro un sacco di iuta grezza, adagiata a pochi metri da un mare blu cobalto. Fra le maglie del tessuto, l’ossuta ferraglia osservava mio padre con malcelato nervosismo, mentre il vecchio iniziava a dilungarsi in una sterminata sequela di possibili approcci al problema del suo montaggio e io, che come manualità son peggio di lui, iniziavo a preoccuparmi per la notte ormai incombente. Papà non lo nominò ma intuii che, in una sorta di automatismo, stava frugandosi le tasche alla ricerca del suo regolo calcolatore che, dal punto di vista pratico, sta al montaggio di una tenda come un’improvvida e triste aranciata al celestiale brasato di Carrù.

Fortuna volle che dietro le nostre spalle si fosse materializzato un angelo dalle umane fattezze. Alto, fiero, due occhi straordinariamente intelligenti, il dottor Gerolamo Chiappino era uscito da una Volkswagen color sabbia parcheggiata pochi metri più in là, anche quella, guarda caso, targata Alessandria. Trentaquattrenne medico della Clinica del Lavoro di Milano, originario di Capriata d’Orba, il nostro angelo era in grado di districarsi con eleganza dai grovigli che la vita di campeggio propone con continuità. Ci montò la tenda, insegnò a mia madre a mantenere fresche le ghirbe dell’acqua, a porre il burro sottoterra per conservarlo al meglio e, insomma, ci ricoprì di tutte quelle attenzioni necessarie al raggiungimento di un dignitoso standard di vita all’aria aperta.
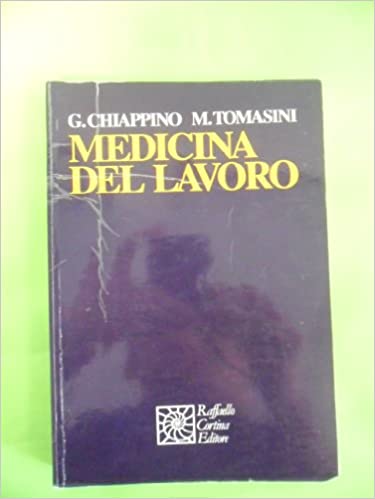
Seppi dopo anni che il suo curriculum professionale si era arricchito al punto di ricoprire il prestigioso incarico di Direttore del Clinica del Lavoro di Milano e in quei giorni, lo confesso, la sua gioiosa e forte compagnia mi affascinò a tal punto da farmi desiderare una laurea in medicina.
L’ho ritrovato solo qualche anno fa, grazie a Facebook, ormai ottantenne, in una casetta fra le alpi bergamasche, piazzata all’ombra di un fitto bosco. Non gliene fregava più nulla della Medicina, dell’università e della città di Milano. Aveva con sé la moglie, gli uccellini, l’orto e migliaia di piante da curare. L’impianto elettrico e l’acquedotto se li era costruiti da solo e sorridendo mi disse che lui, in bagno, aveva il privilegio di farsi la doccia con l’acqua minerale delle fonti San Pellegrino.
È mancato all’improvviso due anni fa, appisolato su di una sedia davanti a casa, sotto il cielo della Val Brembana, portandosi via con sé un pezzo di quelle mie splendide e indimenticabili vacanze a Palinuro.


